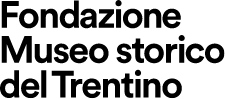Wilma Montesi venne ritrovata priva di vita l’11 aprile 1953 sulla spiaggia di Torvaianica. Il corpo non presentava segni evidenti di violenza e tanto bastò agli inquirenti per derubricare il caso in “tragedia”, nonostante la donna fosse stata ritrovata priva di alcuni indumenti intimi. Il questore di Roma, Saverio Polito, chiuse in cinque giorni il caso elaborando la tesi del “pediluvio fatale”. Wilma quel pomeriggio si recò a Ostia ed entrò in mare per curare un eczema. Al contatto con l’acqua fredda, attraversando in quei giorni il suo “periodo critico”, venne colta da malore, si accasciò priva di sensi, annegò e il suo cadavere venne trasportato dalla corrente fino a Torvaianica.

La stampa avallò tale versione fino alla pubblicazione di un’inchiesta di Silvano Muto che a ottobre, sul settimanale Attualità, aprì uno scenario diverso: la tragedia si sarebbe consumata nella riserva di caccia di Capocotta, un chilometro all’interno del litorale, dove si tenevano festini con giovani donne e personaggi di rilievo. Muto non faceva nomi, ma era noto che il marchese Ugo Montagna gestisse quella riserva. Quel giorno Wilma si trovava in compagnia di un altro uomo quando si sentì male, forse per l’utilizzo di stupefacenti. Il suo accompagnatore e il marchese, allora, pensando fosse morta, decisero di abbandonarla sulla spiaggia. L’altro uomo venne identificato in Piero “Morgan” Piccioni, figlio di Attilio, il democristiano vicepresidente del Consiglio. La notizia, ritenuta dal partito di governo faziosa ed esclusivamente volta a colpire Attilio Piccioni, delfino di De Gasperi e candidato numero uno alla segreteria della Dc, comportò la denuncia di Muto per “diffusione di notizie false e tendenziose volte a turbare l’ordine pubblico”. Il caso divenne così nazionale e l’opinione pubblica si divise tra innocentisti e colpevolisti.
Durante il processo il giornalista rivelò che due informatrici avevano confessato di aver partecipato con Wilma a certi festini a base di stupefacenti con giovani esponenti della borghesia romana, tra i quali si nascondevano i responsabili della morte della ragazza. Una di queste, Anna Maria Moneta Caglio, ex fidanzata di Montagna, affermò d’aver iniziato a sospettare di Piccioni e Montagna a seguito di un loro incontro riservato con il capo della polizia Pavone avvenuto qualche settimana dopo il ritrovamento del cadavere. Il sospetto che Pavone potesse averli favoriti divenne qualcosa di più quando in aula il colonnello dei carabinieri Pompei lesse il suo rapporto su Montagna. Incaricato mesi prima di indagare sul marchese dall’allora ministro degli Interni Amintore Fanfani, esponente della corrente opposta a De Gasperi e Piccioni, l’ufficiale dell’Arma scoprì che questi, durante l’occupazione di Roma, da collaboratore dell’Ovra aveva liberato Pavone dal carcere. Il sottinteso era esplicito: da capo della polizia, Pavone si era sdebitato. La notte stessa, il presidente del Consiglio Mario Scelba lo destituì dalla carica a causa delle “torbide compiacenze al Viminale”, rifiutando però le dimissioni del ministro Piccioni.

In quegli stessi giorni su l’Unità, Pietro Ingrao collegò l’affare Montesi “a uno stato d’animo” comune a milioni di italiani. Per il direttore del quotidiano comunista la vita pubblica del Paese era “macchiata” da “un gruppo privilegiato il quale elude impunemente la legge comune”. Il caso giudiziario Montesi si era così convertito in “una seria questione morale”. Quando in aula Moneta Caglio indicò in Montagna il capobanda di un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti e in Piero Piccioni l’assassino di Wilma Montesi, l’indignazione pubblica fu tale che i giudici rinviarono a data da destinarsi il processo a carico di Muto e riaprirono le indagini sul caso.
La nuova inchiesta fu a quel punto affidata al giudice istruttore Raffaele Sepe e venne ordinata un’indagine amministrativa sull’operato della polizia. Sotto accusa era ormai il sistema di potere che si annidava al Viminale. Attilio Piccioni, obbligato dall’inchiesta giudiziaria, annunciò le sue dimissioni e due giorni dopo vennero emanati i mandati d’arresto per il figlio e per Montagna. I tempi dell’inchiesta furono lunghi ma l’impianto d’accusa risultò ugualmente debole; il processo, spostato a Venezia per ragioni d’ordine pubblico e per garantire l’imparzialità, ebbe inizio solo nel gennaio 1957. In cinque mesi si arrivò al verdetto finale che, pur liquidando come ridicola la tesi del “pediluvio fatale”, stabilì la non colpevolezza di Piero Piccioni, assolto con formula piena. Assolti furono pure Ugo Montagna e Saverio Polito, accusati di favoreggiamento. Le uniche condanne definitive arrivarono dalla Corte di Cassazione nel 1967: Muto e Caglio furono rispettivamente condannati a due anni e a due anni e mezzo per calunnia. Nelle motivazioni, ancora una volta, faceva capolino la tesi del “pediluvio fatale”.

“L’imputato messo sotto accusa dai colpevolisti”, scrisse l’intellettuale Hans Magnus Enzensberger “non pareva essere una persona, bensì una collettività: una classe, una consorteria vasta e potente, una società corrotta, colpevole di aver fatto annegare una giovane donna”. Tra indagini superficiali, depistaggi, lotte politiche, colpi di scena, lungaggini e intrecci oscuri, il delitto Montesi rimane tuttora irrisolto.
Matteo Morsilli
Studente di Scienze storiche dell’Università di Bologna, alla ricerca di tracce del passato e con un debole per le indagini irrisolte. L’archeologia, la storia e la politica sono i campi in cui si concentra il suo interesse.
(Aggiornato al 4 luglio 2024)