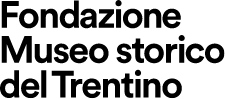Si è nobilitato e si sta nobilitando il passato dello sport, andando a collocarsi nell’ambito della storiografia. Ai molti che non ci credevano – convinti che lo sport fosse soltanto una modalità ludica trascorrere il tempo libero – si rivolse Allen Guttmann, sociologo statunitense, quando pubblicò nel 1978 il libro che lo rese celebre: Dal rituale al record. La natura degli sport moderni. L’opera divenne presto un punto di riferimento per generazioni di studiosi e per tutti coloro che credevano che lo sport fosse anche storia e storiografia, storia e museografia. Se pur in parte superato – sono trascorsi quasi 50 anni dalla prima edizione – il lavoro di Guttmann portava con sé un messaggio che oggi sembra scritto nella pietra: “Gli sport sono allo stesso tempo una alternativa e un rispecchiamento dell’età moderna”. Nella sua semplicità, la citazione ricorda l’importanza della dialettica tra ciò che accade “dentro il campo da gioco” e ciò che accade “fuori dal campo da gioco”: una dialettica fondamentale alla base di Performance, la mostra-evento esposta a Trento a Le Gallerie.

Il percorso espositivo è stato curata dalla Fondazione Museo storico del Trentino e dalla Provincia autonoma di Trento con la prestigiosa partnership culturale del Museo Olimpico situato a Losanna, in Svizzera, e della Fondazione Milano Cortina 2026. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport.

Da molti anni la storia dello sport è oggetto di interesse alla Fondazione Museo storico del Trentino, dove un settore di studi si occupa di questo tema realizzando progetti di ricerca e divulgazione, pubblicazioni, percorsi espositivi e momenti di incontro con il pubblico. L’ultimo importante appuntamento si è svolto lo scorso mese di aprile nella sala conferenze de Le Gallerie, dove per tre giorni è andato in scena il convegno di studi Sport e musei: una sfida possibile. Con attenzione specifica alla storia dell’Olimpismo e dei Giochi Olimpici, il convegno ha proposto una serie di contributi di studiosi differenti in tema di museografia, storiografia, conservazione e valorizzazione di fonti e collezioni. Partecipavano al convegno anche i vertici del Museo Olimpico, che ha collaborato alla realizzazione dell’evento in partnership con la Fondazione. Al Museo Olimpico, situato a Losanna, dove ha sede il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), si trova la più grande biblioteca tematica al mondo dedicata alla storia degli sport olimpici.
Il convegno è stata l’occasione per ripercorrere alcune tappe del percorso culturale che, non soltanto livello nazionale, ha portato negli ultimi decenni a una valorizzazione sempre crescente della storia dello sport come disciplina storiografica e come oggetto di museografia.
Dopo il dibattito acceso dall’opera di Guttmann, i primi contributi che compaiono in Italia su pubblicazioni di natura accademica volte a valorizzare il significato storiografico dello sport – non solo un insieme di record e pratiche competitive ma una componente importante della società e della sua complessità – sono degli anni ’80, dalle colonne della rivista Quaderni storici. Nell’articolo Lo sport, un’innovazione vittoriana, pubblicato a firma di Edoardo Grendi nel 1983, l’autore sottolineava la necessità di superare il disinteresse della storiografia – non solo italiana – verso questo tema.

Più o meno contestualmente, cominciarono a scriverne anche gli autori di Lancillotto e Nausica. Critica e storia dello sport. Era il 1984 e così fu chiamata la prima rivista dedicata alla storia dello sport e ai suoi significati. Il primo numero uscì nel mese di aprile di quell’anno e venne accolto con grande entusiasmo. Dalla stampa nazionale la nuova rivista fu descritta come una “impresa unica e coraggiosa in un panorama italiano di critica sportiva desolante”.
Negli anni ’90 queste discussioni proseguirono anche sulle colonne di un’altra rivista: Italia contemporanea, a seguito dell’articolo pubblicato da Stefano Pivato: Le pigrizie dello storico. Lo sport fra ideologia, storia e rimozioni. Nel contributo, ha scritto più recentemente Domenico Elia, Stefano Pivato “tacciava di pigrizia intellettuale lo storico italiano, considerato incurante dello sport e dei temi culturali e sociali ad esso attinenti. Il dibattito che ne seguì si rivela di fondamentale importanza per comprendere, a distanza di oltre vent’anni dalla sua pubblicazione, gli indirizzi di ricerca che gli storici dello sport avrebbero preso di lì a poco, favorendo – ecco questo è importante, dico io – una fioritura di studi che ha parzialmente scagionato gli storici italiani dalle accuse di pigrizia e di rimozione dello sport dalle loro ricerche”.
Gli ultimi esempi in ordine di tempo sono i molti contributi presenti nei Quaderni della Società Italiana di Storia dello Sport, la collana che pubblica, a cadenza variabile, raccolte di saggi e monografie su temi inerenti la storia dello sport, su coordinamento e per iniziativa della Società Italiana di Storia dello Sport, nata nel 2004. In ambito convegnistico, invece – ricordando soltanto i lavori più recenti – si pensi a Lo sport e i suoi archivi. Produzione, uso e conservazione, tenutosi a Viterbo all’Università della Tuscia nell’autunno del 2023 a cura di Aidusa, l’Associazione Italiana Docenti Universitari Scienze Archivistiche (ampio dibattito, archivi dello sport e per lo sport). E al convegno I luoghi dello sport. Storie, culture e architetture, tenutosi a Firenze nel novembre del 2024 a cura della Società Italiana di Storia dello Sport.
Si è giunti così alla consapevolezza, anche in ambito accademico, che lo sport non sia soltanto sport ma che abbia a che fare con la storia, con la politica e con i cambiamenti della società. Molti esempi valgono in questo senso.

In pieno centro storico, a Trento, via Mantova appare oggi come un piccolo monumento alla storia dello sport e ai suoi significati. Una vicenda che ci porta indietro di 125 anni, nella seconda metà dell’800, quando nelle città d’Europa cominciava a diffondersi il ciclismo con il nome di velocipedismo. Succedeva anche in Trentino. Cresceva il fenomeno delle gite e dei grandi raduni, dove decine di velocipedisti si davano appuntamento promuovendo alleanze tra club e momenti di socialità. Spesso i raduni erano mossi da sentimenti politici. Il 31 maggio 1903 fu organizzato un raduno a Mantova, dove si presentarono più di mille velocipedisti trentini, arrivati in bicicletta da molte vallate. I trentini si erano spinti a Mantova perché parlavano italiano – qui era Austria-Ungheria – sottolineando così il loro spirito di italianità. Si creò un legame forte tra mantovani e trentini. Tanto che, alcuni anni dopo, in occasione di un congresso polisportivo tenutosi a Trento il 23 agosto 1908, i mantovani decisero di ricambiare il gesto, promuovendo un raduno in terra trentina. Si presentarono a centinaia e invasero le strade della città. Tanta fu la partecipazione che si decise di intitolare ai mantovani una via del centro. Via del Macello Vecchio, così si chiamava prima del raduno, prese il nome dell’attuale via Mantova.
(Aggiornato al 30 giugno 2025)