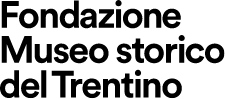Fonte di pericolo e risorsa, la presenza dei corsi d’acqua ha sempre giocato un ruolo ambivalente nei percorsi di antropizzazione alpina e di sedentarizzazione dell’uomo nei territori di montagna. Se, da un lato, l’acqua si offre come elemento indispensabile per la crescita di una comunità e per lo sviluppo delle economie di base, dall’altro, la vicinanza a fiumi e torrenti espone al rischio di esondazioni. Come altri importanti fiumi dell’Arco alpino, l’Adige rappresenta un caso evocativo di questa storia.
Le prime notizie che riguardano un piano di sistemazione del corso del fiume Adige mediante la realizzazione di arginature e di rettifiche risalgono alla metà del 1700. In questo periodo l’imperatrice Maria Teresa d’Austria inviò nel Tirolo meridionale una commissione di esperti con il compito di esprimersi su questioni legate allo sviluppo urbanistico della città di Trento. All’ordine del giorno vi era la necessità di sanare vaste aree di paludi malsane che impedivano lo sviluppo urbanistico ed erano sovente causa di malattie.
Nello stesso periodo, il 5 aprile del 1747 il Governo austriaco decretò una prima sovvenzione di 150.000 fiorini per favorire un piano di studio finalizzato alla sistemazione del corso dell’Adige. L’impegno assunto dall’amministrazione rappresenta un primo segnale di attenzione verso la necessità di una tutela del territorio del fondovalle nelle aree del Tirolo meridionale a favore della prevenzione del rischio alluvionale.
Nei decenni successivi l’interesse crebbe e professionisti sempre più qualificati si alternarono nella produzione di progetti volti a promuovere un piano organico per la regimazione del fiume. Tra questi vi furono l’idrografo Isidoro Leporini, che a partire dal 1774 avanzò diverse proposte, e l’ingegnere Nowack, appartenente al Corpo del Genio dello Stato maggiore dell’Impero d’Austria, che nel 1805 realizzò un progetto di “sistematico raddrizzamento del corso del fiume fra Sacco e Merano da valle verso monte mediante eliminazione delle tortuosità con tagli radicali” corredato da apposite mappe.
Il progetto di Nowack segnò nei primi dell’Ottocento un cambio di passo. Scopo primario divenne la regimazione e rettificazione dell’Adige insieme ad altri interventi sui principali corsi d’acqua come l’Avisio, il Brenta, il Chiese, il Leno, il Noce, il Sarca. Centinaia di opere furono portate a termine. A rendere possibile il cambiamento furono alcuni fattori concomitanti: una nuova e più favorevole legislazione statale, una più decisa spinta imprenditoriale, una certa innovazione di strumenti e tecnologie e, soprattutto, gli effetti nefasti dell’alluvione del 1882.
Tra le opere portate a compimento durante l’Ottocento, vi furono anche i cosiddetti tagli d’ansa: le sistemazioni più significative sul fiume Adige. In ragione degli “interventi a drizzagno”, così erano conosciuti, il fiume assunse l’aspetto con cui oggi lo conosciamo, quello di un paesaggio costruito.
I principali tagli d’ansa furono compiuti tra il 1850 e il 1889 con la finalità di ridurre le aree soggette a esondazioni. Tra Merano e Marco se ne contarono ben 25, che produssero un accorciamento del fiume di circa 15 chilometri, 8 dei quali in Trentino. Sul totale, infatti, 9 tagli d’ansa avevano interessato il tratto dell’Adige compreso oggi negli attuali territori della Provincia autonoma di Trento: taglio di Lidorno taglio di Ischia Perotti, taglio di Masetto, taglio di Centa e Briamasco (a Trento), taglio di Nomi/Calliano, taglio di Marco Tierno, taglio di Chiusole, taglio di Besenello, taglio di Ischia Wolkenstein. A motivare il piano di interventi fu principalmente la necessità di mettere in sicurezza gli abitati della valle dal rischio di inondazioni.
La realizzazione degli interventi di taglio lungo il fiume s’intrecciò anche con il lavoro per la costruzione della ferrovia del Brennero. In quel periodo, tra il 1853 e il 1859 vennero progettati e realizzati i tratti ferroviari da Verona a Trento e da Trento a Bolzano. Le rettifiche dell’Adige agevolarono notevolmente il cantiere ferroviario, poiché, grazie ai tagli d’ansa, le rotaie poterono seguire in vari punti un andamento più regolare e meno tortuoso, risparmiando tra l’altro la costruzione di alcuni punti sul fiume.
Gli interventi a drizzagno ebbero infine importanti conseguenze di tipo viabilistico commerciale. Il fiume Adige rappresentava a quei tempi un’importante via di comunicazione poiché numerosi scambi avvenivano per fluitazione. La navigabilità delle sue acque aveva favorito lo sviluppo di rapporti commerciali fra comunità diverse. I tagli d’ansa velocizzarono il traffico fluviale accorciando le distanze e riducendo i tempi di percorrenza.
Complessivamente, gli effetti positivi della regolarizzazione dell’Adige ebbero il merito di ridurre brillantemente il rischio di esondazione nei pressi dei centri abitati e delle aree coltivate. Ma presentarono anche alcuni limiti. Gli effetti positivi della regolarizzazione furono in parte indeboliti da una scarsa considerazione di una “visione di bacino”. Alla regolarizzazione del corso del fiume non corrispose la sistemazione a monte degli affluenti principali nelle vallate laterali né la realizzazione dei tagli seguì sempre un andamento “da valle verso monte”, come i progettisti avrebbero richiesto. In certi casi, cioè, l’intervento “a drizzagno” fu realizzato prima nei tratti verso la sorgente e soltanto dopo verso la foce. Gli effetti negativi di questi due comportamenti si manifestarono drammaticamente nell’alluvione del 1882.
In ogni caso, i progressi compiuti nel corso dell’Ottocento rappresentarono uno straordinario passo avanti nella storia della difesa del territorio, ponendo le fondamenta per la nascita delle istituzioni moderne.
(Aggiornato al 30 settembre 2025)