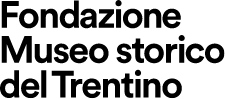“SETE è una parola che esprime urgenza. Può essere anche di conoscenza, di giustizia, di vita. Per questo il nome mi è piaciuto subito”. Emanuele Lapiana, sound designer e fondatore dell’agenzia oSuonoMio, spiega così la scelta di assegnare questo nome a due iniziative dedicate al tema dell’acqua. “Un argomento che mi sta a cuore, d’attualità nel mondo e che popola le nostre discussioni. Da qui è nato un bisogno narrativo”.
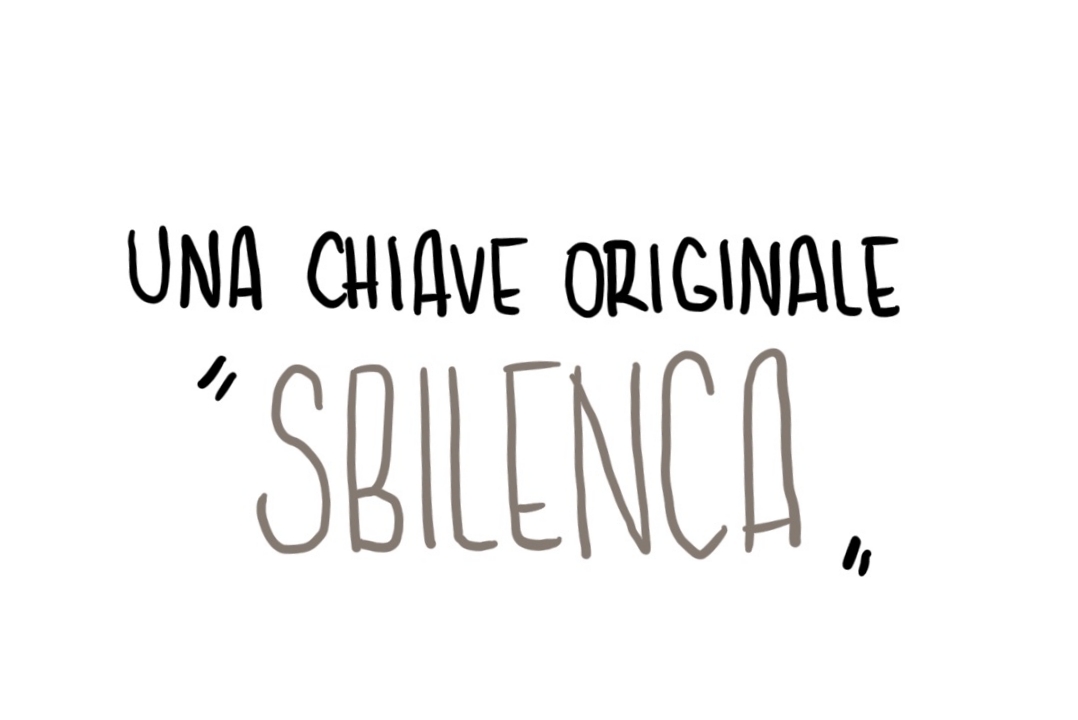
Assieme al giornalista, autore e musicista Gianluca Taraborelli, Lapiana immagina un podcast che affronti la questione con una chiave originale, “sbilenca” la definisce lui. Uscito nel 2021 per la produzione di Eurostandard, azienda che realizza giunti in polietilene per la rete idrica, “Sete. La Grande Transizione” racconta un futuro che ha alle spalle una terribile crisi idrica. “Ambientato in un futuro distopico ma non troppo, dove tutto è andato bene grazie a un gruppo di persone che ha battagliato perché tutto si risolvesse al meglio, una ragazza si mette sulle tracce della mamma che ha combattuto la grande siccità fra il 2039 e il 2080”, racconta.
Ricorrendo alla fiction e senza ideare realtà post-apocalittiche in cui la terra è ormai landa desolata e inabitabile, gli autori di “Sete” partono dall’esigenza di parlare del tema dell’acqua in modo nuovo e diverso. “In maniera sbilenca e laterale – precisa Lapiana – per noi l’originalità è una necessità e allora, visto che non volevamo raccontare l’ennesima avventura in cui tutto va male, abbiamo scelto di usare un approccio che fosse più leggero e normale”.

“La fiction è la chiave per sconfiggere questo tempo maledetto in cui tutti pensano di poter dire qualcosa su tutto, perché permette di affrontare anche temi divisivi, come quello ambientale, su cui le diverse generazioni hanno idee diverse. Se i più giovani sono più sensibili al tema, qualcuno della mia generazione potrebbe invece dire che il riscaldamento globale sia solo una cazzata. Di fronte a una birra, se gli spiegassi i motivi per cui non lo è, probabilmente non riuscirei. Ma se un prodotto di finzione gli piace, magari svilupperà un’altra sensibilità”, aggiunge.
All’origine del podcast, come detto, ci sono discussioni e attenzione verso il tema. Ma, spiega Lapiana, c’è anche la voglia di creare momenti di incontro su un aspetto chiave del mondo che verrà. “Nella mia testa, ancor prima del podcast, c’era l’organizzazione di un festival che non si limitasse alla prospettiva del risparmio idrico ma che parlasse di acqua in termini politici. Arrivato il Covid, un evento del genere non si poteva più fare. Ragionando con Gianluca, abbiamo quindi deciso di scrivere un podcast”.
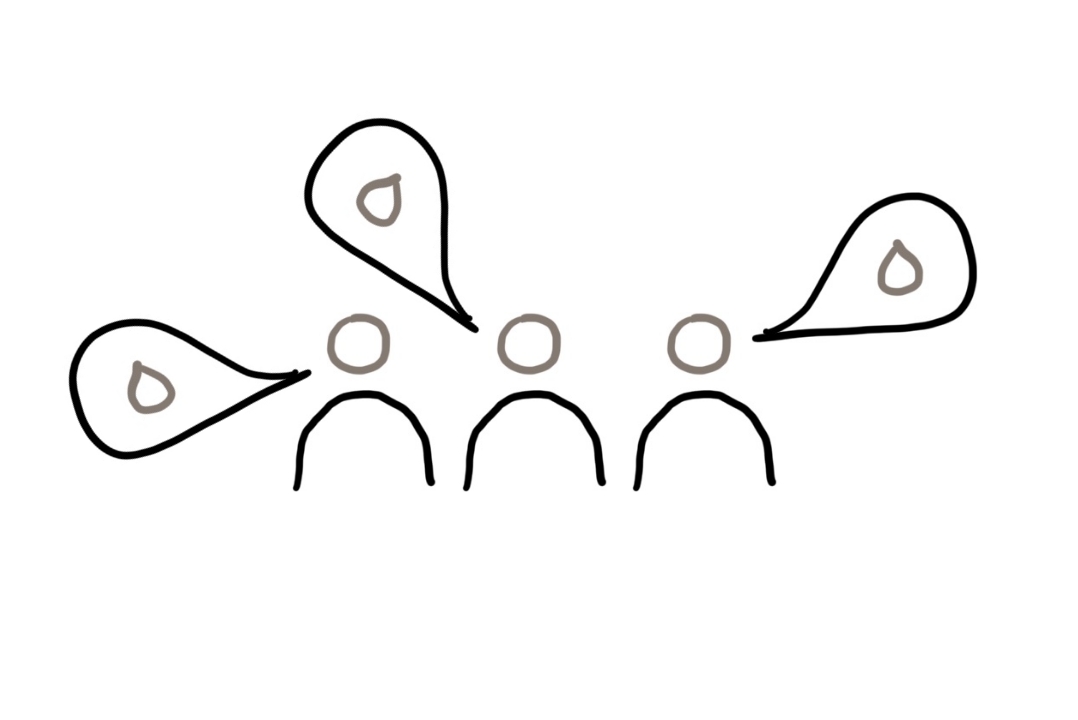
L’idea del festival, però, non è tramontata e nel 2023 e nel 2024 si sono tenute le prime due edizioni. “L’approccio scelto è relazionale, dopo un periodo come quello del Covid in cui ogni impostazione di questo tipo, a casa come al lavoro o con gli amici, è stata spezzata. Nell’epoca dei social, siamo diventati più individualisti, abbiamo l’impressione di essere più informati, di possedere la verità assoluta ma viviamo in una bolla. Basti guardare a quanto sta accadendo in Palestina: dici che è un disastro e ti danno dell’antisemita. Non si può parlare, discutere”.
“Allora abbiamo deciso di mettere attorno a un tavolo persone diverse. C’erano panel con operatori del Mart e attivisti di Ultima generazione, con politici e fumettisti, con musicisti e ingegneri dell’acqua. Nella prima edizione, si è ragionato su come l’acqua sia relazione e viceversa. Tutti la usiamo e tutti pensiamo che il nostro bisogno d’acqua sia giustificato. Mettere in relazione persone così diverse è un’occasione per renderci più attenti alle esigenze di tutti, superando un approccio oggigiorno dominante, che sull’acqua come sull’ambiente, tende a responsabilizzare il singolo più che la collettività. Invece è giusto fare pressioni politiche e ragionare da collettivo”.
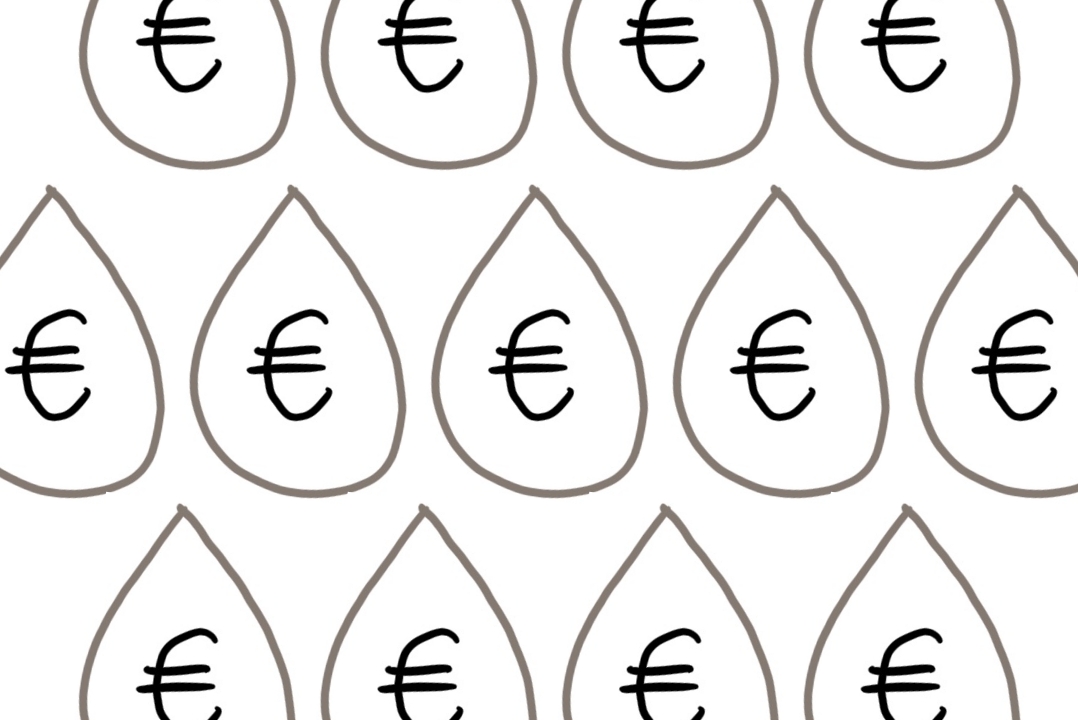
“Nella seconda edizione ci siamo invece occupati di un altro aspetto che fa relazione: i soldi. I costi del cambiamento climatico sono molto più alti di quelli che potremmo pensare, basti guardare alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le persone tendono a credere che le misure per affrontare il riscaldamento globale costino di più del mettere in atto misure di prevenzione, ma è esattamente il contrario”.
Ma eventi del genere quali impressioni danno sulla consapevolezza di istituzioni e società civile rispetto a questi temi? Secondo Lapiana “la consapevolezza delle istituzioni mi pare che ci sia. Ma ciò che è successo nell’ultimo anno sta relegando il tema ambientale in secondo piano. L’agenda, almeno in Occidente, è cambiata. È un discorso interrotto. Parlare del cambiamento climatico come crisi è sbagliato, perché la crisi è passeggera, invece si tratta di un fatto. È un problema più per noi che per la natura, di cui noi siamo solo una parte”.
(Aggiornato al 30 settembre 2025)